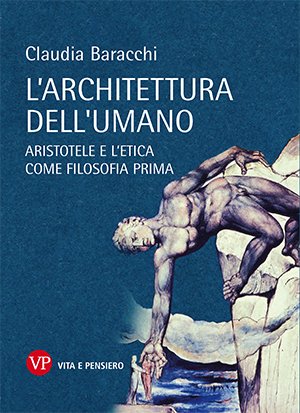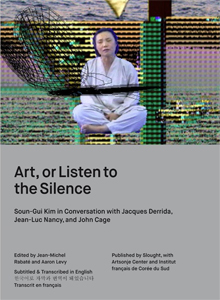Claudia Baracchi, L’architettura dell’umano. Aristotele e l’etica come filosofia prima (Vita e Pensiero, Milano 2014)
Recensione di Stefania Consigliere
Aristotele non figura, di norma, fra i filosofi di una genealogia desiderante, possibile alleato di escursioni critiche ed estatiche. È vero, semmai, il contrario: se immaginiamo la filosofia greca come una famiglia viennese di fine Ottocento, posto Platone come ingombrante Grande Madre, Socrate come antenato scomparso in circostanze sospette, una
pletora di zii fricchettoni e tutti noi come figli, nipoti e pronipoti, Aristotele è il Padre per eccellenza, colui che opera la castrazione della progenie in nome di un sano principio di realtà. Basta pensare alla Scuola di Atene di Raffaello. Non per nulla, è immancabilmente ad Aristotele che la storia dei vincitori fa risalire i primi tentativi riusciti di formalizzazione e canonizzazione delle scienze: dalla logica alla tassonomia, dalla fisica alla psicologia.
E anche dal punto di vista politico non si scherza: meno visionario di Platone, e quindi meno incline alla generosità e ai pericoli che questi corre (la Repubblica è il paradiso comunistico dei filosofi-guerrieri o un incubo totalitario? Se la domanda suona peregrina alle sensibilità critiche raffinate, è perché siamo troppo lontani dai banchi di scuola e dalla verifica che essi costituiscono), Aristotele figura fra i grandi conservatori, ovvero fra coloro che, disponendo di una mappa del mondo chiara e distinta e avendo imparato a separare con cura i desideri dai fatti, trovano infine nel mondo, e sia pure obtorto collo, la loro misura.
Fin qui, si direbbe, siamo alla caricatura: padre castrante, grande conservatore, geometra delle scienze – suvvia, Aristotele non è solo questo… Vero, ed è proprio ciò che l’Architettura dell’umano dimostra. Ma il fatto è che oltre alla filosofia “alta”, quella degli specialisti (filosofi di professione, storici della filosofia, grecisti, antropologi della Grecia antica), c’è anche, per ciascuna cultura, una «filosofia con la gente dentro», come la definisce Tim Ingold: una mentalità comune e condivisa della quale fanno parte le idee ricevute, gli schemi percettivi, le associazioni, l’immaginario. Ora, nella «filosofia con la gente dentro» dell’Occidente scolarizzato, l’immagine di Aristotele che portiamo dentro di noi somiglia dappresso alla caricatura che ne ho appena fatto. E non solo presso coloro che la filosofia l’hanno orecchiata a scuola: qualche mese fa ho assistito a un seminario condotto dall’autrice, da cui soprattutto i filosofi sono usciti sorpresi e quasi sbigottiti dall’epifania aristotelica che ne è emersa.
La sorpresa dei filosofi rimanda al pesce della celebre metafora di Linton, secondo cui la cultura è per gli umani che la vivono come l’acqua per il pesce che vi nuota dentro: l’elemento che caratterizza e rende possibile l’intera vita del pesce, ivi inclusa la sua visione, è anche quello che resta ai suoi occhi invisibile. Ciò che maggiormente determina è ciò che meno può essere riconosciuto – il che apre la più tipica delle domande antropologiche: come arrivare a conoscere il mezzo? attraverso quali stratagemmi, quale arte di funamboli, arrivare a vedersi come da fuori?
All’idée reçue di Aristotele come Padre logicizzante, normativo, istituzionale, si risponde di solito o con la sottomissione del bravo figliolo destinato a entrare in possesso dell’eredità (è, da sempre, la strategia di quella che Ernst Bloch definiva “destra aristotelica”), oppure col gesto impaziente del figlio ribelle, alla ricerca di un nuovo inizio e di genitori altri. Tertium non datur, come insegna papà. Ma sarà poi vero che proprio quello era l’insegnamento paterno? Anche l’alternativa a due vie fa parte degli automatismi che bisogna arrivare a decostruire. Vengono in mente le letture femministe della terza parte di Gita al faro: James, che riceve l’elogio del sig. Ramsey per come conduce la barca, può passare dalla posizione di rifiuto a quella di accettazione del padre semplicemente accedendo all’ambito “maschile” del fare, dell’operare materialmente; per sua sorella Camille, invece, le cose sono più complicate, più lunghe; richiedono una maggiore attenzione e la capacità di spiazzarsi, di decentrare lo sguardo.
La prestazione propria dell’Architettura dell’umano è appunto questa: l’attenzione critica alla materia del testo consente il decentramento dello sguardo, della percezione. Non a caso, l’autrice propone nuove traduzioni dei testi, evitando di appoggiarsi alla filologia mainstream delle traduzioni classiche, e Aristotele torna a parlare una lingua piena di vuoti, che descrive un paesaggio assai poco monolitico. Il panorama che ne emerge è, appunto, sorprendente, e andrebbe rispettato nella sua costruzione paziente. Ciò nonostante mi permetto qui di indicare, telegraficamente, alcune delle acquisizioni più importanti.
C’è, per cominciare, un trascorrere di posizioni fra metafisica ed etica nella scala naturae delle specie filosofiche. La theoria non sta più al vertice della gerarchia, attività astratta e separata che si autogoverna secondo i suoi propri principi, ma risulta continuamente impegnata, e implicata, nel divenire: nell’esperienza, dunque, e quindi nei sensi, nella scelta, nella politica. E non in un secondo tempo, come una star che scenda dal palco e si mescoli alla plebe tumultuante, ma proprio geneticamente: la teoria è figlia di quella «grande confusione sotto il cielo» che, nel quotidiano, fa inciampare ed esitare; figlia degli eventi che, nel verificarsi, impongono delle scelte; figlia di un divenire che non è deliberazione razionale, ma risposta (entusiastica a volte, altre volte dolente, o ambigua, o sofferta) a una forza che attraversa l’essere e lo muove. La conoscenza e l’episteme sono dunque infine irriducibili alla dimostrazione logicizzante: gli stessi principi primi delle scienze, indimostrabili in quanto fonte di
ogni successiva dimostrazione, trovano qui, nell’esperienza del mondo, la loro origine a-teoretica – e se tutti convengono sulla loro affidabilità, è perché tutti hanno trovato, nella loro vita materiale di soggetti immersi in un mondo, che tali principi fossero sempre verificati nella pratica.
(Ancora a proposito dei rapporti fra metafisica ed etica, conviene notare che il trascorrere di posizioni non equivale a un rovesciamento: non si tratta di mettere l’etica al posto della metafisica e riprodurre così, a parti scambiate, un medesimo ordine gerarchico. Teoria ed esperienza sono parte del medesimo posizionamento nel mondo, hanno una stessa origine – e questa origine è esistenziale.)
Questo ci porta dritti a uno dei temi più tipici della riflessione di Deleuze e dei suoi eredi: il desiderio. In questo Aristotele la forza che muove gli enti, che li costringe al divenire e, per così dire, alla verità di se stessi, non è un’attività deliberata o attivamente scelta, ma il desiderio per qualcosa, di qualcosa. Desiderio come forza che si subisce, che costringe: ma anche principio di trasformazione, forza genetica che spinge al divenire, alla compiutezza, e quindi verso la verità di se stessi.
Se tutto ciò suona strano (e, come abbiamo visto, non può che essere così), si provi a rileggere la frase che apre la Metafisica: «Per natura tutti gli esseri umani desiderano l’avere visto». La traduzione più comune, chiosa l’autrice, è «desiderano la conoscenza»; ma εἰδέναι è, alla lettera, avere visto. Nelle pieghe della filologia si nascondono, a volte, delle vere e proprie rivelazioni, e “conoscere” non significa “aver visto”: fra le due lezioni ci sono di mezzo l’evoluzione storica della cosmovisione occidentale, le trasformazioni del soggetto, un diverso rapporto col divenire e l’ingresso in ciò che, maldestramente, chiamiamo modernità.
L’età moderna della storia della verità è iniziata solo a partire (…) dal momento in cui il filosofo (o lo scienziato, o anche solo chi cerca la verità), è diventato capace di riconoscere la verità, e ha potuto avere accesso a essa, in se stesso, e in virtù dei suoi soli atti di conoscenza, senza che da lui si esiga più nient’altro, ovvero senza che il suo esseredi soggetto debba essere modificato o alterato in alcun modo (Foucault, L’ermeneutica del soggetto, pp. 19-20).
In questo paradigma – che è poi il nostro – la conoscenza è un insieme di informazioni razionalmente padroneggiabili da un soggetto nel pieno possesso delle sue facoltà. Nell’aver visto aristotelico, invece, nel conoscere ne va del soggetto: la conoscenza è qualcosa che accade, non qualcosa che si ha; è una trasformazione, non una mnemotecnica. Non a caso, mentre la conoscenza fa pensare all’Enciclopedia Britannica, l’aver visto evoca invece Eleusi, quella visione misteriosa di cui non si doveva e poteva fare parola, ma che cambiava per sempre la vita dell’iniziato (meglio ancora: che ne cambiava per sempre lo statuto soggettivo).
Lo spunto critico è dei più fecondi, dacché permette di riaprire la discussione sulla moderna separazione fra soggetto e conoscenza, che fa del primo un ricettacolo razionale e della seconda un insieme di dati oggettivi. In questo quadro la relazione fra soggetto e conoscenza resta sempre esteriore, formale; la conoscenza non trasforma il soggetto, e questi a sua volta, nella sua esperienza di un mondo, non produce conoscenza. viagra sans ordonnance La conoscenza a cui pensiamo nella modernità è in fondo l’analogo, nella sfera cognitiva, dell’equivalente generale nella sfera economica: qualcosa che, come i soldi, più se ne ha, meglio è. Qualcosa che non si può controeffettuare: nessuno mai, in nessuna circostanza, vorrebbe avere meno conoscenza… (A riprova: nessuna scienza ha mai rifiutato di accogliere dei dati, indipendentemente dal modo – talvolta infame: è il caso delle sperimentazioni nelle sale di tortura – in cui erano stati ottenuti.) Per contro, se, come ci dice Aristotele, è per natura che gli umani desiderano l’aver visto e quindi la trasformazione di sé, allora è immancabilmente per storia che possono trovarsi a desiderare di non aver mai visto, maledire la conoscenza raggiunta per via del prezzo esorbitante che essa è costata. È quanto insegna l’intera tragedia: è per aver visto che Edipo, coerente, si acceca.
Un’ampia analisi critica delle forme di conoscenza e del loro rapporto coi soggetti che le praticano (o che ne sono praticati) avrebbe implicazioni enormi: per la filosofia e la sua storia, per l’antropologia, per la psicologia, per la politica. E anche, a ben vedere, per le singole esistenze soggettive, alle prese col fatto che il dogma centrale della modernità – la separazione fra fatti e valori – non è più praticabile. Ma questo, appunto, è ciò che ai prossimi anni resta da pensare.
Intanto possiamo festeggiare l’arrivo di questo Aristotele, così diverso da quello che credevamo di conoscere. Diverso e affidabile: la forza del libro di Claudia Baracchi sta anche nell’ostinazione con cui procede, nella pazienza dello smontaggio e del rimontaggio, nell’acribia delle citazioni e delle connessioni. E se sono senz’altro i filosofi, in quanto detentori del canone, i primi a dover fare i conti con questa nuova fotografia del loro antenato, la portata di questa rilettura trascende i confini (sia pur labili) della disciplina, intersecando la profonda revisione epistemologica attualmente in corso e investe un intero esercito di questioni calde che attraversano il pensiero critico, l’antropologia, la storia, la politica.
Qui mi limito a elencarne un paio. La prima riguarda la calcificazione che affligge tutte le tradizioni quando sono lasciate troppo sole con se stesse, e che riverbera immediatamente sulla capacità cognitiva e sulla sensibilità di coloro che ne sono plasmati. Ciò porterebbe a un lungo discorso sulla vacuità dell’accademia (e, per inciso, non solo di quella italiana): da quanto tempo la filosofia, e in particolare la storia della filosofia, serve solo alla carriera accademica dei filosofi professionisti? Perché nelle manifestazioni nessuno brandisce, non dico Marx, ma almeno Spinoza? Nello scrivere questa recensione per «La Deleuziana» mi rendo conto con sgomento che l’ultimo grande maestro a me noto che sapeva leggere i pensatori antichi in modo da renderli non solo vivi, ma assolutamente cruciali per la vita quotidiana, era proprio Gilles Deleuze. C’è bisogno di riprendere quelle letture: con quell’intensità.
Poi c’è la questione capitale del rapporto con la pluralità dei mondi e con le conseguenze che essa porta con sé. Rifiutando la partizione classica fra una natura e tante culture, l’antropologia contemporanea va teorizzando che ciascuna forma umana dia origine a un mondo – tanto complesso quanto quello “occidentale” che ha plasmato noi, e irriducibile alle nostre categorie ontologiche, epistemologiche ed etiche. Si parla quindi, in questi anni, di multinaturalismo, e le riflessioni sviluppate nell’ambito del cosiddetto ontological turn sono della massima rilevanza per tutti coloro che scalpitano nella riduzione accademica della filosofia a disciplina specialistica. Non c’è modo, qui, di dire di più – salvo questo: la principale implicazione che emerge da tutto questo discorso è, ancora!, l’inscindibilità di ontologia, conoscenza, etica e politica già incontrata sopra.
In questo campo vasto, magmatico e decisivo, l’Aristotele desiderante proposto da Claudia Baracchi è un alleato – e dei più potenti. Proprio per questa ragione mi permetto, in chiusura, di avanzare all’autrice un’irrituale richiesta.
La forza di questo libro ne costituisce anche il limite. È sempre così, certo, ma questa volta vale la pena di osservarlo, perché si tratta di un limite valicabile. L’architettura dell’umano è un testo per specialisti: 370 pagine fitte, dense di rimandi e di nuove traduzioni dei brani aristotelici più rilevanti, che attraversano sistematicamente l’Etica nicomachea e fanno affondi ampi in parti della Metafisica e degli Analitici posteriori. Non si arriva a smontare l’immagine di Aristotele trasmessaci dal canone senza un corpo a corpo di questo tipo con la materia testuale, né a imbastirne una differente senza affrontare l’hegeliana fatica del concetto.
Sarebbe importante, però, che questa lettura non restasse confinata all’ambito dei filosofi professionisti e diventasse uno strumento per tutti coloro che, oggi, stanno provando a ripensare l’Occidente e la modernità, i suoi presupposti, la forma umana che esso produce e la sua capacità di lasciar vivere altri mondi. E se, come detto, il libro qui recensito è riferimento solido e scientificamente inappuntabile, esso andrebbe messo alle spalle di un altro libro a venire: un saggio agile, affilato, che permetta a coloro che, all’interno dell’Occidente, si stanno inoltrando nella molteplicità di poter ancora far riferimento ai propri antenati.